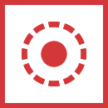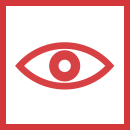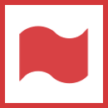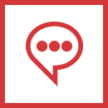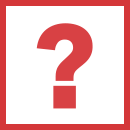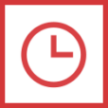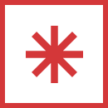Il geologo e divulgatore scientifico lancia l’allarme: “le grandi città non reggono alla crisi climatica, serve una strategia per ridurre i divari territoriali”
Ormai da tempo assistiamo ad un fenomeno che vede le aree interne del Paese spopolarsi. Queste zone rappresentano circa la metà dei Comuni italiani, il 60% del territorio nazionale, e vi risiedono più di 13 milioni di persone. Nel contempo le grandi città sono sempre più espanse e caotiche. Mario Tozzi, tu che Italia vedi nel futuro?
Non bisognerebbe favorire questo accentramento nei grandi centri. Tra l’altro, la vita in città non è che abbia una qualità particolarmente superiore. Le periferie-satellite, dove magari gli affitti costano un po’ meno, non hanno nemmeno lontanamente la qualità della vita che potrebbe avere il centro storico. E quindi comunque si è costretti a fare molti spostamenti, di una-due ore, per andare a lavorare. Come se ti muovessi da un paese dell’entroterra. Quasi quasi, quindi, converrebbe rimanerci. Le grandi città non sono preparate, non lo sono nemmeno da un punto di vista ambientale: rischiano alluvioni, ondate di calore, complessivamente non reggono alla crisi climatica. Non si incrementa adeguatamente il verde urbano, che consentirebbe di diminuire la temperatura che, anzi, aumenta, facendo registrare 4\5 gradi in più rispetto alle aree circostanti di campagna; in più sono coperte di asfalto e cemento che rendono tutto più caldo e più impermeabile. Rispetto alla crisi climatica non c’è niente di peggio delle città moderne del mondo.
Questi territori risultano penalizzati sulle prospettive di lavoro, di sviluppo, sui servizi: di cosa ci sarebbe bisogno per invertire la rotta?
C’è bisogno di un collegamento più stretto, sostenibile. Non sono le strade che mancano, ma le ferrovie leggere e le comunicazioni dei dati. I servizi essenziali, come quelli sanitari, sarebbero significativi. Quando mancano quelli, la cosa si fa complicata. Se poi parliamo del lavoro, in quelle aree lì è fortemente caratterizzato dalla piccola manifattura e dai servizi al turismo. Questi territori potrebbero caratterizzarsi per i servizi di conoscenza, innovazione, tecnologia, come peraltro già fanno alcune realtà.
Resta il pericolo di overtourism?
Ci sono realtà provinciali che sono già “perdute” da questo punto di vista: penso a Pienza, Montepulciano, Gaeta, Taormina. Sono comunità completamente al servizio del turismo, ma questo accade anche nelle grandi città: il centro storico di Roma, Firenze, Venezia. Qui trovi soltanto accoglienza, ristorazione e souvenir. Dovremmo guardare alla Francia, che è il Paese più visitato al mondo ma, allo stesso tempo, quello che mantiene meglio la sua identità. Quindi, anche in Italia si può puntare ad un turismo più intelligente, penso ad esempio agli alberghi diffusi, oppure penso ancora alla provincia abruzzese, alla provincia laziale, anche a quella maremmana. Territori che, pur essendo molto visitati, non arrivano a spersonalizzarsi.
Investire nelle aree interne contribuisce anche alla riduzione dei divari…
Si. L’area marginale non deve essere un posto solo visitato ma anche abitato. Certo, il divario è difficile da azzerare, però sarebbe importante sapere che quel divario nelle aree marginali è una specificità che deve essere attrazione e non ostacolo.
Cosa ne pensi delle iniziative di alcuni Comuni che offrono contributi economici affinché le persone vi si trasferiscano, ad esempio la vendita di case a prezzi simbolici?
Può essere un’idea, ma io credo che non dovrebbe essere consentito il cambio di destinazione d’uso. Se in un locale c’era un artigiano, è opportuno che venga mantenuta un’attività artigianale e non consentire che si facciano sempre e comunque strutture ricettive.