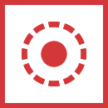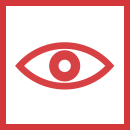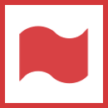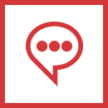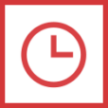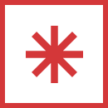Ester Cois è PhD in Sociologia del genere e della famiglia, sociologa del territorio presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari, membro della sotto-commissione nazionale CRUI per i Gender Equality Plan e Delegata del Rettore per l’uguaglianza di genere. Spazio Pubblico, in occasione dell’8 marzo, l’ha intervistata.
Passare dagli stereotipi all’identità di genere: come si affronta questo percorso?
In quanto meccanismi cognitivi di semplificazione della realtà, finalizzati ad elaborarne in modo rigido e sostanzialmente condiviso l’estrema complessità ed eterogeneità, gli stereotipi di genere risultano essere profondamente radicati nelle fondamenta di qualsiasi contesto sociale e culturale, da cui sono costantemente alimentati e che, al contempo, contribuiscono a riprodurre. In particolare, l’attribuzione netta di una serie di connotazioni molto precise al concetto stesso di cosa sia (o dovrebbe essere) un uomo e cosa sia (o dovrebbe essere) una donna – all’interno di un’ottica strettamente binaria e, per certi versi, speculare – definisce sin dalla nascita delle carriere morali maschili e femminili che trasmettono un campionario di comportamenti socialmente attesi cui non è facile sfuggire sin da bambini/e, in un’opera incessante di “normalizzazione” che tende a sanzionare più o meno esplicitamente ogni forma di divergenza dai modelli appresi, già durante le prime fasi della socializzazione primaria, quando è l’educazione familiare a indicare i confini di ruolo che, se trasgrediti, portano a tacciare negativamente come “maschiacci” le bambine “troppo” assertive e come “femminucce” i bambini “troppo” sensibili. La socializzazione secondaria, esperita nel perimetro scolastico e nell’esposizione costante ai mezzi di comunicazione di massa, in generale favorisce un rafforzamento di questi percorsi dicotomici di genere, utilizzando il giudizio dei pari come formidabile dispositivo di assimilazione o, viceversa, di stigma ed esclusione, a seconda della buona riuscita o meno del processo di identificazione nel campionario di pratiche concesse ai maschi e alle femmine. Le conseguenze più rilevanti di questa spinta incessante alla conformità di genere, che costituisce la principale fonte di potenza degli stereotipi, sono, in primo luogo, la spersonalizzazione dei singoli individui, cui è richiesto più uno sforzo di adattamento a modelli omologanti che non un esercizio di acquisizione di effettiva consapevolezza di sé, e di promozione dei propri desideri, aspirazioni e prospettive soggettive. In seconda istanza, questa forte induzione sociale alla corrispondenza ai modelli stereotipici maschili e femminili produce l’essenzializzazione di questi stessi modelli, cioè la credenza che siano diretta espressione della natura originaria, addirittura geneticamente e biologicamente determinata, ascritta a uomini e donne, a prescindere da ogni coordinata spaziale e temporale, come se provare a diventare qualcosa di “diverso” rispetto all’inventario dei percorsi tracciati in ragione della categorizzazione sessuale assegnata all’atto della nascita fosse un vero e proprio tradimento della propria vocazione più intima e costitutiva. Perché questa cosmogonia binaria ammetta deroghe, permutazioni o ribaltamenti, è indispensabile riconoscerne l’origine non dogmaticamente “naturale”, ma piuttosto connessa a una costruzione socio-culturale databilissima nel tempo e del tutto circoscrivibile nello spazio geografico di riferimento. E tutto ciò che è costruito, può essere decostruito, o riformulato in combinazioni dinamiche, mobili, differenti. Solo che imputare il compito della decostruzione ai singoli individui, ciascuno per la propria singola biografia, è una fatica immane, e il più delle volte insostenibile. Vivere da “eccezione permanente alla regola” comporta una tensione identitaria, in direzione ostinata e contraria, di difficilissima manutenzione, ed è impensabile fondare sull’eroismo di pochi/e apriprista il compito di riconoscimento e promozione delle diversità e di contrasto a ogni forma di discriminazione basata sul genere. L’opportunità, o meglio, il diritto di definire una propria identità pubblica e visibile che assomigli il più possibile all’idea che ciascuno ha di sé, di come vorrebbe e non necessariamente dovrebbe essere – per citare il meraviglioso monologo di Agrado in “Tutto su mia madre” di Pedro Almodovar – in una società che si pretende democratica non può che essere un contenuto di cittadinanza sostanziale garantito collettivamente, in condizioni di equità per uomini e donne, di “pari opportunità”, appunto. Eppure, questo diritto collettivamente sancito all’espressione di un’identità di genere individualmente scelta non ha di certo le sembianze di un passaggio neutro o indolore, se pensiamo al modo stesso in cui il nostro regime di welfare pubblico continua a funzionare, continuando a fare affidamento su una complementarietà obbligatoria di ruoli di genere tra uomini procacciatori di reddito da lavoro remunerato (i cosiddetti “male breadwinner”) e donne erogatrici universali di cura (le cosiddette “female caregivers”). Anche questa è una semplificazione, certamente, ma proprio per questo conserva la forza consolidata di un collante del tessuto minimo della società a cui è difficile resistere od opporsi, soprattutto fintanto che la relazione tra singolo individuo e attore pubblico resterà obbligatoriamente mediata dall’appartenenza a modelli familiari altrettanto stereotipici – primissimi luoghi di formazione alla contrapposizione di genere – anziché assumere i connotati di un universalismo capace di trattare davvero uomini e donne non egualmente, ma “da eguali”, come cittadini/e a pari e pieno titolo.
Politica, istituzioni, società, associazionismo: c’è un attore principale in una strategia di contrasto alle discriminazioni di genere, oppure tutti hanno la stessa quota di responsabilità?
Parafrasando i celeberrimi versi di Francesco De Gregori, “la Storia siamo noi, nessuno si senta offeso”. Lo stesso potrebbe dirsi dei meccanismi di rappresentanza politica, che dovrebbero tradurre in decisioni a valenza collettiva le nostre scelte elettorali. Dell’azione delle principali istituzioni che fondano e regolano i nostri mondi sociali, dai curricula formativi che accompagnano il nostro divenire adulti dalla scuola dell’infanzia fino all’università, alle condizioni di accesso, permanenza, progressione e uscita dal mercato del lavoro, tra porte e soffitti di cristallo o tubi che perdono “risorse umane” in esubero durante il proprio ciclo di funzionamento. Delle cause civili, politiche, culturali che decidiamo di abbracciare e che sorreggono la nostra postura ad associarci e a dare una voce più stentorea (quella dell’unione, che amplifica le parole dei singoli) alle nostre rivendicazioni e un respiro più pragmatico ai valori che coltiviamo. Se tutti questi luoghi della cittadinanza e della partecipazione – politica, istituzioni, associazionismo – continuano a reiterare l’adesione a un modello organizzativo cristallizzato sulla distinzione e complementarietà obbligatoria tra carriere morali di genere maschili e femminili – ogni cosa/persona al suo posto, un posto per ogni cosa/persona – risulta difficile scombinare le carte, così come aprire spazi di condivisione di ruoli, compiti e responsabilità “aperti”, in condizioni di equità, a uomini e donne, perché il concetto stesso di discriminazione, diretta o indiretta (e cioè di esclusione argomentata e non casuale, in ragione del genere di attribuzione, da certe funzioni e posizioni, in genere più prestigiose o ambite) decadrebbe, a fronte di un salutare dispositivo di mantenimento dell’ordine costituito e, tutto sommato, trasversalmente accettato, in quanto solido e rassicurante, da larghe quote di uomini e di donne, in nome di automatismi ben rodati e interiorizzati. E pazienza se il loro vero volto è quello della subalternità di genere. Quindi sì, la quota di responsabilità è equamente ripartita tra chi decide, chi regola e chi non rivendica modalità alternative di pensare, organizzare e agìre il mondo sociale che ci è toccato in sorte. Nessuno/a si senta offeso/a.
Il mondo accademico è promotore di cultura e di innovazione. Qual è la sua esperienza nel settore?
L’Università costituisce certamente un laboratorio permanente di produzione e diffusione culturale d’eccellenza, così come un terreno di sperimentazione di pratiche innovative di ricerca, studio e lavoro, oltre che di promozione di un capitale umano non solo altamente qualificato, ma anche investito del compito di farsi espressione tangibile di inclusività, giustizia sociale, affrancamento dalle condizioni diseguali di partenza, di qualunque matrice esse siano, genere compreso (ma in un’ottica intersezionale, che non può certo abdicare all’intreccio con i fattori di classe, di salute e di connotazione etnico-territoriale d’origine). La mia personale esperienza, negli anni più recenti, è di coinvolgimento diretto nell’elaborazione e implementazione di policies inclusive e anti-discriminatorie in ambito accademico, in funzione del mio attuale ruolo di Delegata del Rettore per l’Uguaglianza di Genere e Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Cagliari, a partire dal 2021. In verità, il mio interesse attivo per il tema della parità di genere risale a tempi molto più precoci della mia esperienza universitaria, sin da quando ero una giovane matricola presso la facoltà di Scienze Politiche ed ebbi la classica illuminazione sulla via di Damasco per effetto della partecipazione al corso di Sociologia Generale tenuto dalla prof.ssa Anna Oppo, storica voce del pensiero femminista italiano, che mi aprì un mondo di riflessioni e di presa di consapevolezza di quanto lontani fosse, ancora, il traguardo della cittadinanza perfetta, anche per le donne del mio Tempo, anche nel comodo alveo del mio Paese, preteso avamposto di democrazia ed equità su scala globale. A quell’interesse ho dato poi corso più operativo con il conseguimento di un Dottorato di ricerca in Sociologia del Genere, della Famiglia e dell’Infanzia presso l’Università di Torino, qualche anno dopo, sotto la supervisione di un altro riferimento fondamentale dei Gender Studies a livello internazionale, la prof.ssa Chiara Saraceno. E questa specializzazione è stata anche il nucleo principale della mia attività didattica e di ricerca quando sono tornata all’Università di Cagliari, in seguito, non più nelle vesti di studentessa, ma in quelli di ricercatrice e docente di Sociologia, dall’altra parte della cattedra rispetto a generazioni di studentesse e studenti pronti a raccogliere il testimone nella lunga marcia verso un mondo meno asimmetrico tra uomini e donne, al volgere del nuovo Millennio. Uno dei punti di svolta che ha infine marcato la mia transizione verso la governance d’Ateneo è stata la partecipazione, dal 2018, al gruppo di ricerca che per conto dell’Università di Cagliari ha rappresentato l’Italia nel partenariato internazionale europeo del progetto Horizon2020 SUPERA (Supporting the Promotion of Gender Equality in Research and Academia, https://www.superaproject.eu ) con il coordinamento del Prof. Luigi Raffo, grazie al quale, già dal Giugno 2020, la mia università si è dotata di uno dei primi Piani di Uguaglianza di Genere in Italia, al punto da farmi reclutare come componente della sotto-commissione nazionale CRUI per le tematiche di genere, dedicata ai Piani di Uguaglianza di Genere, a partire dall’anno successivo, con la finalità di elaborare – insieme a un pool di colleghe provenienti da svariate università della penisola – le linee guida ufficiali per la stesura di questi piani da parte di tutte le altre istituzioni accademiche del nostro Paese. Il Piano di Uguaglianza di Genere (o GEP) costituisce la colonna vertebrale dell’architettura organizzativa d’Ateneo finalizzata crescentemente a promuovere pratiche eque e inclusive per uomini e donne, e a contrastare ogni forma di discriminazione persistente sotto questo profilo, agendo su quattro aree tematiche principali attraverso ben 32 azioni strategiche mirate, da implementare nell’arco di un triennio, per poi essere rinnovato con la medesima cadenza: reclutamento, mantenimento, progressione di carriera, politiche di conciliazione famiglia-lavoro (segregazione orizzontale e verticale); leadership e processi decisionali (responsabilità, trasparenza, inclusione); dimensione di genere nella ricerca e nella didattica; contrasto dei pregiudizi e stereotipi di genere, sessismo e molestie sessuali. Un ulteriore rafforzamento dell’impegno dell’Università di Cagliari su questo fronte, e che mi vede tuttora direttamente coinvolta in sua rappresentanza, è derivato dalla partecipazione come full partner al progetto europeo Erasmus+ SMILE (Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe, nell’area “Women in Leadership”, https://smile.eucen.eu ), che vede dal 2019 e fino al 2023 un partenariato internazionale impegnato nella produzione e divulgazione di strumenti operativi per garantire, in condizioni di equità, il conseguimento del successo formativo e il raggiungimento delle posizioni apicali in ambito accademico a tutti/e gli studenti/esse e ricercatori/ici che sperimentino condizioni di maggiore vulnerabilità di partenza, in ragione del genere di attribuzione, della condizione socio-economica e del background migratorio. In particolare, all’interno di questo progetto sto collaborando alla messa a punto di tre strumenti che poi saranno messi a disposizione di tutte le Istituzioni di Alta Formazione che vorranno avvalersene nello spazio europeo: un modello di “Diversity Audit” per auto-valutare la propria situazione, come università, in termini di indirizzo politico già attivato in senso inclusivo e di promozione delle diversità; tre Corsi di Formazione Professionale continua, uno per ciascuno dei settori tematici di potenziale vulnerabilità sopra menzionati; un modello di Action Plan per l’implementazione e monitoraggio di meccanismi di equità intersezionale sostenibili e replicabili in contesti accademici differenziati. Infine, la mia attuale funzione di Presidente del Comitato Unico di Garanzia, un organo paritetico preposto ad assicurare il benessere organizzativo all’interno dell’ambito universitario di studio e di lavoro, mi offre un osservatorio prezioso per rilevare le criticità ancora persistenti nella vita quotidiana di un Ateneo che vede interagire ogni giorno oltre 25.000 studenti/esse e 2000 professionisti tra personale docente e tecnico-amministrativo. Ad alcune di esse stiamo cercando di dare peculiare risonanza e, tra tutte, cito l’impegno che dalla fine del 2021 l’Università di Cagliari ha assunto come interlocutrice privilegiata nell’ambito del progetto europeo UNISAFE (Ending Gender-Based Violence. Gender-based violence and institutional responses: Building a knowledge base and operational tools to make universities and research organisations safe, https://unisafe-gbv.eu ), finalizzato a rilevare e contrastare il fenomeno della violenza di genere e del sessismo in ambito accademico, insieme ad altre 45 istituzioni universitarie in tutta Europa.
In questo processo quale crede debba essere il ruolo degli uomini?
Nel corso della mia esperienza biografica e accademica ho maturato la convinzione crescente che il poderoso cambiamento culturale imposto dal perseguimento di una effettiva equità di genere, che non si esaurisca nella vuota retorica dei discorsi di maniera da riproporre ogni 8 Marzo o 25 Novembre, ma che garantisca un ampliamento reale delle opportunità aperte alle bambine e alle ragazze in ogni ambito sociale, politico ed economico, come contenuto di cittadinanza sostanziale e non come privilegio o gentile concessione, non solo ammetta, ma esiga in modo ineliminabile la partecipazione consapevole e convinta di tutte e tutti. Proprio perché l’obiettivo è sia quello di affrancarsi dalle maglie di un concetto binario, dicotomico e oppositivo di genere, che veda uomini versus donne in una lotta intestina perenne per un ribaltamento dei meccanismi di subalternità, in vista, semmai, sia di non aspirare a una società che neutralizzi o omologhi le differenze, che di per sé fanno la ricchezza del mondo, ma che si impegni attivamente per valorizzarle al massimo e per impedire che si trasformino in disuguaglianze. Chi occupa posizioni apicali, e quindi decisionali, in questo momento, come in ogni altro momento storico, è ancora in larga misura di genere maschile – ce lo dicono i numeri, se è vero che, per esempio, a fronte della prima Presidente del Consiglio di genere femminile, la quota di parlamentari resta ancorata ad appena il 33%, o che il numero delle donne rettrici in Italia non raggiunge ancora il 10% delle università pubbliche -. Ed è dunque chi può decidere a essere chiamato ad assumersi le proprie responsabilità di rappresentanza collettiva, di tutti e tutte, per abbracciare convintamente l’obiettivo dell’equità di genere, partendo dall’assunto che non si tratta di un gioco a somma zero, per cui l’esercito di riserva delle donne che scalpitano dietro l’angolo andrebbe a invadere, soverchiare, e sostituire la popolazione maschile in ogni settore della vita pubblica e privata, ma piuttosto di un investimento esponenziale positivo per il benessere di tutti e tutte. Un gioco win-win che non solo è giusto e doveroso sotto il profilo etico, ma che è anche decisamente più conveniente, molto prosaicamente, ai fini della produzione del PIL e quindi del benessere generalizzato, come dimostra cifre alla mano, per esempio, la riflessione avviata da Maurizio Ferrera nel suo “Il Fattore D. Perché il lavoro delle donne farà crescere l’Italia”, già nel 2008, mettendo in evidenza come lo spreco e il mancato impiego di oltre una metà della popolazione, quella femminile, spesso già formata o potenzialmente tale quanto a investimento in capitale umano, sia un’inspiegabile e insostenibile zavorra per i processi di crescita degli Stati Nazionali.
Come impatta il gender gap nella vita di tutti i giorni?
Il gender gap è un elemento fondativo e pervasivo della vita di tutti i giorni, sotto gli occhi di chiunque sin da quando si acquisisce coscienza di sé, per cui semmai sarebbe arduo trovare isole felici dove questa discrasia non sia manifesta, sebbene a livelli differenti di intensità. Mi limito a qualche esempio molto spicciolo. Il quadro tracciato dall’ultimo Gender Policies Report dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), diffuso a gennaio, rivela un tasso di disoccupazione femminile ancorato al 9,1% rispetto al 6,8% per gli uomini, un gap che peggiora nella fascia d’età più giovane fino ai 24 anni. La più ostica transizione verso l’autonomia per le ragazze italiane è misurata dall’Osservatorio Indifesa di Terre des Hommes, che attribuisce al nostro Paese il pesante record europeo negativo in termini di percentuale di ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (almeno visibilmente), pari al 25%. E anche quando la porta di cristallo si apre, l’ingresso nel mercato del lavoro prelude troppo spesso per le giovani donne a un confinamento in settori fondamentali per la sussistenza del nostro modello di Welfare, ma con basse remunerazioni e scarsa portata strategica, nella narrazione pubblica. Le donne guadagnano tra il 20 e il 24% in meno, in media, dei loro colleghi uomini, e il maggiore ricorso al part time, che riguarda il 49% dei contratti attivi femminili rispetto al 26.2% degli uomini, è un ulteriore fattore di fragilità economica e finanziaria, sempre meno negoziabile o ascrivibile a scelte effettive di investimento nella propria biografia personale e familiare, ma semmai imposto dalle regole del mercato, a gradi di libertà tendenti allo zero, entro una cornice di generale precarietà delle posizioni a tempo determinato. Gli equilibrismi della conciliazione tra lavoro e vita privata, ben presto tornati nei ranghi consueti dopo la breve e controversa glorificazione dello smart working, continuano a coinvolgere maggiormente la componente femminile, ben poco dirimente nei processi organizzativi, dal momento che se in Europa nel 57% dei casi la decisione sugli orari di ingresso e uscita spetta esclusivamente al datore di lavoro, in Italia questa assenza di flessibilità riguarda il 76% dei casi. E nel mio mondo, quello che conosco meglio, l’ambito universitario? Se l’Italia anche nel 2022 è rimasta alla 63esima posizione nella classifica mondiale della parità di genere, definita dal World Economic Forum sulla base del Global Gender Gap Index calcolato su 146 Paesi, lo deve anche alle forme di segregazione orizzontale (solo il 20% di iscritte nei corsi di laurea STEM nel 2020/21) e verticale (appena il 26% dei professori ordinari erano donne nel 2021) che continuano a connotare l’ambito accademico, sebbene i numeri del MUR attestino che le studentesse rappresentano stabilmente oltre il 56,6% degli iscritti ai corsi di laurea e ben il 57,2% del totale dei laureati.
Elly Schlein leader Pd, Giorgia Meloni Presidente del Consiglio, Silvana Sciarra a capo della Corte Costituzionale, Margherita Cassano, prima donna nella storia d’Italia a guidare la Corte di Cassazione: che “forza” porta al raggiungimento della parità di genere l’aumento della presenza femminile ai vertici delle istituzioni?
Per rispondere partirei proprio dall’occasione dell’8 Marzo, ogni 8 marzo. Una data che è ben lungi dall’essere una gioiosa celebrazione di quell’“altra metà del Cielo” che fatica ancora ogni giorno per rivendicare il proprio diritto paritario, molto più pragmatico, alla terra, e a ciò che essa contiene in termini di accesso al mercato del lavoro, raggiungimento delle posizioni apicali nella rappresentanza politica, libertà effettiva di scelta rispetto alle proprie aspettative familiari e personali. L’8 Marzo è piuttosto, come ogni anno, un memento di quanto sia necessario continuare a tenere il passo, a non fermarsi, a esplicitare a voce piena e ferma che, fintanto che gli indubitabilmente grandi traguardi raggiunti da alcune donne – la Presidenza del Consiglio, la Guida del principale partito di opposizione, la Guida della Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Comando della Stazione Spaziale Internazionale – resteranno codificati come straordinarie eccezioni, la possibilità di farne una regola accessibile a tutte resterà lontana, e non consentirà soste celebrative troppo lunghe. Dunque, ben vengano “le prime volte” e le “prime donne” in ogni settore finora rimasto dominio intangibile maschile. Sono uno straordinario segnale e una fonte di gratificazione che straborda nello spazio collettivo, oltre il prestigio strettamente assegnato su base individuale al merito delle donne che “ce l’hanno fatta”. Ma questo è un primo passo, che se fine a se stesso non supera il passaggio della mitizzazione del singolo (anzi, della singola). Noi siamo cittadini e cittadine, non followers, e fintanto che le donne che faticosamente hanno conseguito le posizioni di maggiore potere in ogni ambito non attiveranno una narrazione meno focalizzata sulla straordinarietà delle proprie biografie eroiche, ma più improntata all’esplicitazione dei meccanismi che hanno reso loro possibile farlo, e che quindi potrebbero essere riattivati anche da altre donne, tutte quelle che potrebbero venire dopo o in futuro, forse resteremo nella sfera delle icone laiche, ma non degli effettivi “role models” e tantomeno dei processi di mentoring per le ragazze più giovani. Perseguire l’eccellenza è un’ottima aspirazione, che dovrebbe essere coltivata nella misura in cui si combina alla fattibilità dell’impresa, in condizioni di opportunità formative, professionali, culturali, economiche garantite davvero su basi di equità e normalità. Perché se le eccellenze restano figure per definizione irraggiungibili e non replicabili, dalla pulsione alla mimesi si passa alla frustrazione asintotica, e questo non è un vero cambiamento, ma una conferma del vecchio adagio per cui l’eccezione non fa che confermare una regola ben solida, quella del “per pochissime, ma non per tutte”. Inoltre, siamo davvero sicure che basti raggiungere la posizione di vertice nella sfera del potere praticato per potere affermare che questo sia un indicatore di parità raggiunta? E se quel modello di potere restasse ancora profondamente patriarcale, imponesse costi ben più pesanti in termini di rinunce (per esempio alla vita personale e familiare) alle donne rispetto agli uomini, o usasse le poche donne al vertice come mero “token” per darsi una ripulita estetica nell’immaginario collettivo, senza di fatto cambiare i suoi presupposti asimmetrici fondanti, siamo davvero certe che è quello che vogliamo per le bambine e le ragazze più giovani? E se a cambiare dovesse essere quel modello di potere, e non la struttura d’azione (e perfino di personalità!) delle donne che vogliano/possano aspirarvi? Don’t fix the women, fix the system!
Non ci sono solo comportamenti di evidente stampo maschilista. Ci sono anche atteggiamenti che, senza rendercene conto, portano con sé quel modello culturale, e sono i più subdoli e complessi da scardinare. Come possiamo accorgercene?
In genere ce ne accorgiamo quando siamo noi, in prima persona, a subirne le conseguenze, di cui percepiamo improvvisamente e con assoluta lucidità l’incongruenza e l’ingiustizia. In questi casi, temo che la microfondazione dell’esperienza valga più di molta riflessione astratta, che pure è assolutamente necessaria per potere riconoscere e dare un nome alla prima, e anche per pensare a delle possibili soluzioni. Oltretutto il maschilismo e l’orientamento patriarcale sono delle posture trasversali, che possono essere interiorizzate tranquillamente tanto da uomini quanto da donne, oppure non esserlo da entrambi, proprio in quanto costruzioni sociali, antropiche, umane, non determinanti naturali del nostro essere uomini e donne. Al volo, mi viene in mente un esempio. A molte sarà capitato di presentarsi a un colloquio di lavoro e sentirsi chiedere, con un atteggiamento sgradevolmente invasivo e indagatore, se nell’orizzonte degli eventi prossimi venturi ci sia per esempio il desiderio di avere un figlio/a, oppure un secondo/a figlio/a, restando immerse nella tangibile sensazione che quella possibile scelta d’azione sia tanto stigmatizzata e sanzionata a livello individuale – perché pregiudicherebbe la performatività della neo-assunta a rischio di congedo di maternità – quanto esaltata e fortemente incitata a livello pubblico (almeno a parole, meno nei sostegni pubblici in termini di servizi). Cos’è, se non un paradosso profondamente maschilista, quello che colpevolizza le donne (e in particolare le donne, e con molta maggiore ferocia rispetto a quanto non accada agli uomini) sia che facciano un figlio/a sia che decidano di non farlo? O zavorra nei bilanci d’impresa, nel primo caso, o colpevoli inadempienti dell’abisso demografico del nostro Paese, nel secondo, chi – se non le donne – è sempre comunque indotto a mettere a tema la questione, sopra ogni legittima aspirazione soggettiva?
I diritti delle donne, ma anche i diritti umani in senso trasversale, in molte parti del mondo non sono garantiti. Cosa si può fare?
Informarsi. Tenerne traccia. Testimoniare. Sfruttare ogni occasione possibile per dare voce a quanti/e se ne vedono privati/e nei contesti d’origine. Non fingere empatia intermittente, sulla scia dei fatti di cronaca, per poi passare ad altre notizie più fresche e dirompenti. Non indulgere alla noia o all’assuefazione dell’eccesso di informazione globale, dalle comodità della propria echo-chamber protetta. Non pensare che ciò che accade in un mondo profondamente globalizzato, non mi riguarderà o non mi raggiungerà mai (e le crisi pandemiche, climatiche ed economiche globali non fanno che decostruire questa convinzione fallace). Ragionare in termini trasversali, intersezionali, contestando una mentalità neo-feudale che pensa bastino muri, altri muri, per impedire la contaminazione dell’ingiustizia tra un Paese e l’altro. Fare pressione sui propri governi connotati da basi costituzionali democratiche perché adeguino le proprie relazioni geopolitiche in modo sincronico alle palesi violazioni dei diritti umani (e di genere, in particolare) da parte dei governi che le praticano, nell’impunità del mondo. Per esempio, a leggere le cronache globali sui quotidiani di oggi, 8 Marzo 2023, una notizia colpisce con tanta forza da togliere il fiato: quella delle oltre 5000 ragazze iraniane frequentanti i licei e le scuole secondarie inferiori che sono state gravemente intossicate, ai danni del sistema respiratorio, nel più recente tentativo del regime di soffocare la Rivoluzione civile che da molti mesi ha acceso il Paese, al grido di Donna, Vita, Libertà. Il feroce simbolismo della sottrazione della voce, a queste giovani donne, praticato proprio nei luoghi di formazione dedicati ad alimentarne le parole attraverso l’istruzione, costituisce uno dei tasselli più potenti di questo Terzo Millennio attraversato, ovunque, dalla lunga e incessante marcia verso la Parità di Genere. Un percorso non lineare, irto di ostacoli, punteggiato da false partenze e passi indietro, come nel caso della rimessa in discussione dei diritti riproduttivi femminili che ha infuocato l’estate del 2022 in Texas, facendo riecheggiare le strade e le piazze dell’America profonda di migliaia di voci di donne, pronte a proteggere le basi della propria cittadinanza sostanziale così faticosamente conquistata dalle generazioni delle loro madri e nonne. Quindi, i terreni nei quali misurare il proprio attivismo, non mancano, purtroppo.
di Valerio Ceva Grimaldi