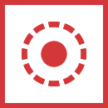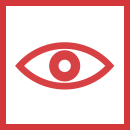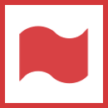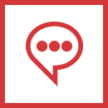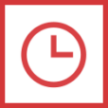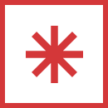Silvia è una dottoressa del Policlinico di Milano. Il mese scorso ha momentaneamente lasciato la sua azienda, ha rinunciato allo stipendio e si è offerta volontaria per salire su una nave Ong e assistere e curare i pazienti a bordo. Quando è salita sulla Humanity 1, a Palermo, ancora non sapeva che presto le sarebbe stato chiesto di fare qualcosa di molto diverso: dopo averli curati li doveva selezionare, e decidere chi poteva scendere e chi no. Le abbiamo chiesto di raccontarci come è andata.
Innanzitutto, come mai la scelta di lasciare il tuo posto e fare la volontaria su una nave Ong?
Ho sempre desiderato fare questo tipo di esperienze. Ho lavorato come medico volontario in Africa e in Sud America. Volevo toccare con mano la questione della migrazione nel Mediterraneo e dare una mano. Un’idea che era nata prima dello scoppio della pandemia e che causa Covid ho rimandato. Così, appena ne ho avuto l’occasione, mi sono messa in aspettativa e sono partita.
Che situazione hai trovato a bordo?
Siamo stati fermi al porto per dieci giorni. Nel mio staff c’erano anche un paramedico, un’infermiera e ostetrica, uno psicologo, un mediatore culturale, una cuoca. Ci siamo preparati per tutti gli scenari di emergenza che potevano presentarsi. Poi siamo salpati e ci siamo diretti a largo della Libia. Abbiamo fatto tre salvataggi: di due barche di legno e di un gommone. In tutto abbiamo fatto imbarcare 180 persone.
In che condizioni erano queste persone?
Erano molto provate dal viaggio. Alcune erano sotto shock perché avevano perso amici e parenti caduti in mare. Dal punto di vista sanitario la maggior parte aveva problemi cutanei, disidratazione, ferite infette, segni di precedenti violenze. Nei giorni successivi le condizioni meteo sono peggiorate e si è diffusa una febbre alta, fino a 39 gradi. Per fortuna i test Covid erano negativi. Col passare dei giorni è stato sempre più difficile gestire il loro stress. Quando hanno capito che li stavano selezionando per sbarcare, hanno fatto tutti uno sciopero della fame. Ero molto preoccupata per le loro condizioni.
Raccontaci cosa è successo…
A un certo punto mi hanno chiesto di selezionare chi far sbarcare. Io ho risposto che non lo avrei fatto, che per me era impossibile eseguire una selezione e che mi sarei limitata a fornire i report che avevo compilato nei giorni precedenti e a dare assistenza. Li abbiamo fatti entrare uno alla volta e sono stati visitati. A un certo punto hanno cominciato a dirmi che i trattamenti che avevo fatto avevano portato dei buoni risultati e che quindi non c’era più necessità per queste persone di essere sbarcate. Per me è stato estremamente difficile accettarlo e soprattutto spiegarlo ai miei pazienti. Mi hanno risposto: “Pensavamo che essere sani fosse un motivo per essere accettati, non il contrario”. Sono state sei ore di selezione, le più lunghe della mia vita.
Come ti sei sentita?
È stato complesso accettarlo, anche da un punto di vista deontologico. Ho vissuto un grande conflitto interiore. Nei giorni successivi ero molto preoccupata che le persone potessero procurarsi dei motivi per essere evacuati. Avevo veramente paura che nella disperazione ci potessero essere degli atti di autolesionismo, come di fatto è avvenuto con lo sciopero della fame.
Come si è conclusa la vicenda?
La prima selezione ha lasciato a bordo 35 persone. Dopo qualche giorno è stata fatta una valutazione psichiatrica e, visto il grado di stress dei pazienti, sono stati considerati tutti ad alto rischio, fragili. E quindi sono sbarcati. Una buonissima notizia nel dramma della vicenda. Io sono tornata a casa ieri mattina. Adesso ho due giorni prima di riprendere la mia normale attività lavorativa. Due giorni che sicuramente mi saranno utili per rimettere un po’ in ordine le idee.
di Martina Bortolotti