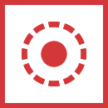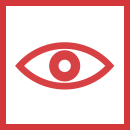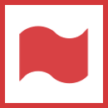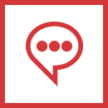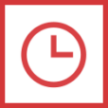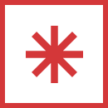Raffaella Setti è professoressa associata di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente con l’Accademia della Crusca dove svolge attività di Consulenza Linguistica.
“Stop all’equazione migrante=clandestino”
Il tema dell’immigrazione è certamente complesso, spesso strumentalizzato o banalizzato. Usare le parole corrette è un modo per prevenire i pregiudizi?
Innanzitutto, una premessa: i cambiamenti sociali portano naturalmente a cambiamenti linguistici. Ciò accade anche con il fenomeno dell’immigrazione, le cui modalità mutano molto rapidamente. La parola migrante, ad esempio, è una parola relativamente nuova. Una volta si parlava di emigrante. Con le nuove forme di migrazione emigrante ha assunto una connotazione “passata”, ha preso su di sé un carico di significati che l’hanno marcata socialmente e storicamente. Ciò è accaduto perché a fronte di fenomeni migratori diversi si sono cercate nuove parole tra le quali, appunto, migrante che è diventata una sorta di passe-partout, che ha sommato in sé più realtà, più modalità di migrare, più motivazioni diverse che sono alla base della scelta delle persone di lasciare il proprio Paese. Il problema è, poi, quello di assumere una comunicazione il più possibile univoca utilizzando parole che siano il meno ambigue possibile. Più le parole sono polisemiche, cioè che possono assumere diversi significati, più ovviamente si lascia spazio all’interpretazione che può, a sua volta, essere indirizzata fino a favorire la formazione di luoghi comuni, stereotipi o addirittura di forme discriminatorie e offensive.
Alcune espressioni evocano già un punto di vista, un messaggio. A partire dalla parola “clandestino”.
Il sentire comune si costruisce. Tutto quello che noi scriviamo, soprattutto i professionisti della parola, chi la usa per diffondere notizie, informazioni, comunicazioni, messaggi, costruisce delle immagini in chi legge e chi ascolta. La parola clandestino ha una sua origine (dall’avverbio latino clam) che vuol dire nascosto. Poi è diventata una parola del diritto, per riferirsi a chi compie qualcosa in maniera nascosta, contro il divieto delle autorità (la segretezza, perché fuori dal tracciato della legge, è la caratteristica primaria di clandestino in espressioni come “matrimonio clandestino”, “bisca clandestina” “stampa/organizzazione clandestina”). Ma da qualche decennio il concetto di clandestinità è divenuto pressoché inscindibile dal fenomeno delle migrazioni. Nominare tutti i migranti che arrivano come clandestini è un abuso, almeno fino a quando non vengono raccolti i dati su queste persone e i motivi per i quali sono arrivati, magari in modo fortunoso e rischiosissimo. I media continuano a operare con il meccanismo della ripetizione performativa che fa prendere forma a immagini e pensieri attraverso la ripetizione esponenziale di parole e associazioni di parole (tecnicamente collocazioni) che diventano lo sfondo (qualcuno lo ha definito “basso continuo” prendendo la metafora dalla musica) della percezione comune. Se vengono associate continuamente le parole migrante e clandestino chiaramente chi legge o ascolta, anche a seguito di una diffusione capillare e velocissima con internet e i social, associa queste due parole in maniera automatica. E quindi diventa un pregiudizio. Poi ci sono altri meccanismi come la semplificazione, la genericizzazione: si affibbiano delle etichette a gruppi, a persone che sono tra loro diverse e spinte da motivazioni diverse. Anche l’aggregazione è un meccanismo classico: considerare i migranti, gli sbarchi, le persone nel loro essere gruppo, mai con una specificità, con un primo piano sulla persona singola. Tutto questo fa sì che si formino queste immagini assolutamente generiche e non rispondenti alla realtà.
Un fenomeno spesso oggetto di propaganda da parte della politica…
Certamente. Lì si tratta di una strumentalizzazione volontaria per orientare l’opinione pubblica. Poi c’è l’amplificazione attraverso i media e i social.
Anche in vista di una fase di campagna elettorale, ritiene opportuno lanciare un appello all’uso delle parole giuste?
Assolutamente sì. Il problema è la volontà. Chi parla pubblicamente o scrive non è sprovveduto. Se ci sono distorsioni sono volute, per orientare. Gli strumenti per contrastare ci sono, per esempio il Glossario sull’asilo e la migrazione della Commissione europea. È un tentativo di fornire una guida terminologica comune a tutti i Paesi europei. Bisogna contrastare la banalizzazione dell’informazione e la strumentalizzazione politica.
Cosa spinge a utilizzare parole con accezioni che evocano paure, timori, preoccupazioni?
Sulla paura si governa meglio. Se si crea paura le persone tendono ad affidarsi a qualcuno che si ritiene possa risolvere il problema e, così, rimuovere la paura. C’è una scarsa propensione ad approfondire, una superficialità anche nell’informarsi. Difficilmente c’è la possibilità di andare più a fondo. Magari tende a farlo solo chi è più interessato o coinvolto. Non bisogna illudersi che sia possibile comprendere un argomento in un decimo del tempo effettivamente necessario: bisogna prendersi il tempo giusto per conoscere, analizzare, per fare una riflessione un po’ più profonda. Sulla questione migrante/clandestino, va detto, ci sono state notevoli discussioni e si è costruito un percorso di sensibilizzazione. Ora però bisogna mantenersi vigili perché in questa fase di campagna elettorale sicuramente gli estremismi e le approssimazioni aumenteranno di nuovo. Ecco perché curare il linguaggio è sempre più importante.
di Valerio Ceva Grimaldi