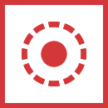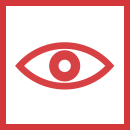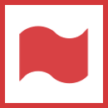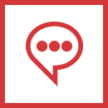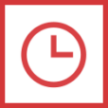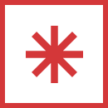Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Nella società di oggi, spesso, il lavoro non viene più considerato come uno strumento che ci consente di avere un dignitoso guadagno e di vivere serenamente la nostra vita. Oggi il lavoro è percepito, piuttosto, come uno status quo, un modo di vivere, che ci qualifica davanti agli altri e tende ad assorbire il nostro tempo.
Un problema soprattutto giovanile
Soprattutto tra i giovani, che si ritrovano a concorrere in una gara spietata verso la poca occupazione che il Paese offre, e che hanno bisogno – per vincerla – di qualificarsi e distinguersi il più possibile, si è innescato un pericoloso meccanismo che vede associati il concetto di sacrificio con il concetto di valore. Ovvero, è giusto che io mi faccia in quattro, è giusto che lavori 10 o 12 ore al giorno e che mi renda disponibile anche nei weekend, se voglio avere successo.
“Un lavoro dignitoso non è un diritto!”
Sembra, dunque, che per avere un lavoro dignitoso, che ci consenta di vivere una vita serena, sia giusto sacrificarsi. Il lavoro non è più un diritto, bisogna guadagnarselo! Una mentalità ormai molto comune e radicata in questa epoca di frenesia lavorativa e produttiva, ma assai sbagliata e pericolosa. È assolutamente giusto impegnarsi nella propria professione e dare il massimo, ma il diritto al lavoro ci appartiene, è acquisito ed è estremamente sbagliato associare il sacrificio del proprio tempo e della propria vita privata ad un requisito necessario per lavorare. Come se senza sacrificio non lo meritassimo.
Il peso delle donne di assentarsi per la maternità
Una delle principali vittime di questa mentalità, ormai radicata tra i giovani cresciuti a pane e qualificazioni, sono ancora una volta le donne. Una donna che aspira alla costruzione di una propria famiglia vive con senso di colpa e vergogna la necessità di assentarsi e di smettere di essere professionalmente produttiva per il periodo della maternità, e per quello successivo di cura del bambino e di conciliazione vita-lavoro. La donna, anche se inconsciamente, si sente un peso, vive con imbarazzo e timore la propria necessaria assenza. Un senso di responsabilità e di colpevolezza che certo l’universo imprenditoriale non tenta di scardinare ma che anzi accredita e alimenta. Agli occhi di molti imprenditori, orientati al profitto, uomini e donne sono valutati in base alla propria produttività e la donna, al confronto con il collega uomo, ha buone possibilità di doversi assentare e di essere dunque meno produttiva in alcuni periodi della propria vita lavorativa. Non sono eccezionali per le donne situazioni di burn-out quando sentono addosso questa etichetta, o la possibilità di vivere spiacevoli situazioni nel fatidico momento del colloquio, in cui capita di essere sottoposte a domande al limite del legittimo (e oltre): “Lei è sposata?”, “Desidera dei figli?”.
Il business man come modello virtuoso
Un pericoloso circolo vizioso che non solo ci fa credere di non meritare un lavoro dignitoso se non siamo disposti a sgobbare e a sacrificare qualcosa di noi, ma che porta oggi a vedere quello del “business man”, che passa l’intera giornata in ufficio, che dorme poco, che non ha tempo libero nel weekend e che trascorre la cena impegnato in una telefonata di lavoro, come il modello vincente. Un modello virtuoso, da ammirare, cui aspirare.
Il fenomeno del “workaholism”
Ma tutto questo cosa comporta? Non solo la fatica nella rincorsa alla qualificazione in più, alle ore di straordinario, alle rinunce personali. Il modello del “business man tutto fare” può sfociare nel cosiddetto “workaholism”: la dipendenza patologica dal lavoro, l’incapacità di staccare la spina, continuando a pensare al proprio lavoro anche una volta a casa. Il workaholism non va confuso con l’entusiasmo per il proprio lavoro, razionale e controllato, o con la dedizione. Il workaholism è una patologia e chi ne soffre non è “un gran lavoratore” ma una persona che ha bisogno di prendersi cura di sé. Questa patologia porta una serie di disturbi psico-fisici come ansia, depressione o sbalzi d’umore, iperattività, insonnia, oltre che la costante tendenza a trascurare il proprio privato.
di Martina Bortolotti
Workaholism e pandemia. L’esperto: “Giovani lavoratori sempre connessi”