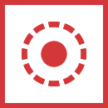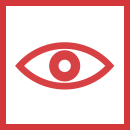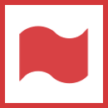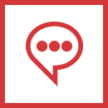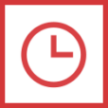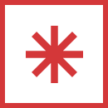Secondo una ricerca quasi 2 milioni di giovani tendono a mostrare segnali di dipendenze comportamentali. L’esperta: “Servono risposte strutturali. Ed è fondamentale che la psicoterapia sia fatta nel Servizio pubblico”
In Italia sono quasi 2 milioni gli adolescenti che mostrano tendenze compatibili con una dipendenza comportamentale: 1,2 milioni dal cibo (coinvolte soprattutto le ragazze), quasi 500 mila dal gaming (coinvolti soprattutto i ragazzi), circa 100 mila dai social media. Il cadere nell’isolamento sociale (cosiddetto Hikikomori) coinvolge circa 65 mila giovani. I dati provengono da un recentissimo studio, ‘Dipendenze comportamentali nella Generazione Z’, frutto di un accordo tra il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, presentato all’Iss.
La ricerca, realizzata con EXPLORA Addiction Research Division, ha coinvolto più di 8.700 studenti tra gli 11 e i 17 anni e 1.044 genitori. Il rapporto ha indagato anche sulle origini di questi problemi, ed è la mancanza di comunicazione con i genitori uno dei tratti che più accomuna i soggetti a rischio: segnala difficoltà comunicative il 75,9% degli 11-13enni con un rischio di social media addiction, il 58,6% dei ragazzi con dipendenza da videogiochi, il 68,5% di quelli che soffrono di una dipendenza grave da cibo e il 77,7% dei ragazzi delle scuole superiori con una tendenza rischiosa al ritiro sociale.
Numeri preoccupanti che abbiamo approfondito con Chiara Aliquò, medico, pediatra, psicologa clinica e psicoterapeuta, dal 2010 al 2020 responsabile UOSD Disturbi del Comportamento alimentare Asl Roma 5 e docente presso la scuola di psicoterapia Bios Psichè.
Come valuta questi dati?
Sono inquietanti e drammatici. Quando ci troviamo di fronte a un comportamento dobbiamo sempre andare a cercare quali siano le sue cause più profonde di questo star male che tende a far diventare un ragazzo dipendente da qualcosa. Bisogna realizzare questo ribaltamento alla ricerca delle cause del malessere.
Tra le cause, la ricerca individua la scarsa comunicazione con i genitori…
Sono i ragazzi che dicono “non riusciamo a comunicare con i genitori”, e dall’altra parte i genitori sembra dicano “io non riesco a capire se mio figlio sta male”. Riflettendo un momento sulla storia dei rapporti tra genitori e figli, mi sono chiesta: c’è mai stata veramente questa comunicazione o la storia del rapporto tra genitori e figli è molto più complessa? Più che alla comunicazione verbale noi dobbiamo fare riferimento a una dinamica di rapporto molto profondo e molto precoce nella vita delle persone: quello con i genitori, con i membri della famiglia. Tanto che possiamo arrivare a dire che la patologia mentale grave dipende, in qualche modo, dal fallimento non tanto di una comunicazione verbale, del parlare, di dirsi i problemi, ma di rapporti che vengono anche prima della comunicazione verbale con l’adulto.
È quindi anche una questione di “presenza”?
Esattamente. Si tratta di “vedere l’altro”. Il giovane, il ragazzo, deve costruire la sua identità anche ribellandosi, nel modo giusto, a quello che viene proposto, non attraverso comportamenti che poi risultano autolesivi come, appunto, le addiction. La comunicazione con i genitori presuppone un rapporto profondo, che si può fare anche silenziosamente, ed è responsabilità del genitore “vedere” il figlio. Il problema del genitore non può essere solo quello di verificare se il figlio ha bisogno di un maggiore controllo perché sta mettendo in atto qualcosa che non va: prima del controllo c’è bisogno di comprensione profonda non solo dei suoi bisogni ma delle sue esigenze di rapporto, di essere “visto”, aiutato, sostenuto nella sua crescita a sviluppare sé stesso, la propria unicità umana, la propria identità. I giovani, oggi, sono in sofferenza. Lo dicono e lo hanno detto: alimentare una visione di eccellenza come una normalità significa mettere in difficoltà tantissimi giovani, significa spingerli verso questa esclusione da una realtà vissuta come troppo pressante, che non rispetta i tempi personali, fisiologici di crescita e maturazione, di fare le scelte giuste. Oggi non si accetta che un giovane sia incerto.
Cosa fare?
I giovani chiedono risposte strutturali. Non solo lo sportello di counseling nelle Università ma, per esempio, di potersi confrontare con specialisti, psicoterapeuti, psichiatri, psicologi, con specialisti esterni all’Università sui problemi con i quali hanno a che fare nella loro realtà e nelle loro difficoltà.
La salute mentale è un ambito che sembra messo da parte, dimenticato. Bisognerebbe investire di più? E come?
Assolutamente sì. Servono, anche qui, interventi strutturali. Il bonus psicologico ha risposto ad una parte infinitesimale delle domande di salute mentale che sono emerse, ma non ha strutturalmente modificato la risposta che il Ssn deve dare a questa richiesta di salute mentale. E ora c’è una novità storica: i giovani non hanno più paura di essere stigmatizzati se dicono di avere una sofferenza psichica e psicologica, novità alla quale il Ssn deve dare una risposta completa, adeguata, unitaria. Altro che autonomie differenziate!
In questo contesto, che ruolo ha la società?
Bisogna assolutamente chiedersi quanto una società che propone una certa visione dell’essere umano è responsabile di generazioni di ragazzi che si trovano in sofferenza. E dobbiamo distinguere la sofferenza fisiologica di un ragazzo che cresce e che deve trovare la sua personale realizzazione, fenomeno che c’è sempre stato, da un malessere più profondo che fa perdere la speranza di trovare una risposta che vada oltre quelle che può fornire l’ambito familiare. Il giovane è ricco di possibilità umane, affettive, intellettive, vitali: spegnere queste possibilità è una responsabilità non solo delle madri, dei padri, delle famiglie – sicuramente questo c’è, naturalmente –, ma se poi la società fornisce risposte ancor più contraddittorie, anaffettive, che distruggono la speranza con cui i giovani si avvicinano e si aprono alla società stessa… Ecco perché è necessario un cambiamento strutturale anche di ciò che la società propone. La società, oggi, dice che se un giovane ha una sofferenza bisogna tacitarla immediatamente, magari dando un farmaco, se no viene colpita la performance. Invece la sofferenza bisognerebbe comprenderla e curarla. La società, negli ultimi trent’anni, ha proposto una cultura di neoliberismo, in cui c’è l’homo homini lupus: i giovani questa cultura l’hanno assorbita e questo fa perdere la speranza della cooperazione tra esseri umani e attiva le rivalità con l’altro anziché la collaborazione e la complicità.
Che ruolo ha la prevenzione?
È strategica. La prevenzione primaria prevede dei progetti a partire dalla scuola dell’infanzia, prevenzione che sia soprattutto informazione corretta, dicendo la verità sulla realtà e sulle possibilità umane. Scuola e università sono luoghi privilegiati dove svolgere questa prevenzione. La fondazione Massimo Fagioli è molto attiva anche in quest’ambito. Poi, c’è un altro tema che considero imprescindibile.
Quale?
È importantissimo che la psicoterapia sia fatta nel servizio pubblico. È un elemento assolutamente fondamentale.
di Valerio Ceva Grimaldi