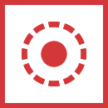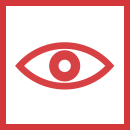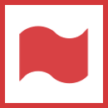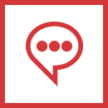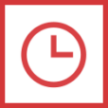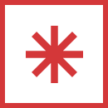L’esperta: “Rimettere al centro delle azioni politiche il tema delle vulnerabilità. Le città devono essere per tutti, non solo per chi riesce a cavarsela”
Annalisa Marinelli è un’architetta, vive e lavora in Svezia. Nel suo libro “La città della cura, ovvero perché una madre ne sa più dell’urbanista” (Liguori 2015) pone l’accento sulla necessità di ripensare le nostre città, i loro spazi e i loro tempi, con l’ottica della vulnerabilità sociale. Una nuova prospettiva che dovrebbe ispirare la progettazione del futuro, con effetti positivi anche per l’economia.
Partiamo dallo spunto del suo libro: perché una mamma dovrebbe essere più brava di un urbanista a “pensare” una città?
Chiunque si occupi di cura lavora con la vulnerabilità, con un elemento che è rimosso dalla progettazione e dall’idea della costruzione della nostra società che è fondata sulla produzione, il lavoro. Ciò che sfugge ai bilanci – e gli economisti l’hanno detto, soprattutto negli ultimi decenni – è che quando si parla di lavoro si omette il tema della cura, che è un presupposto che ci rimette al mondo tutti i giorni e ci consente di lavorare ed essere produttivi. Se non teniamo conto di questo tema all’interno delle nostre vite, non potremo mai risolvere i problemi.
Lei sostiene anche la necessità di una vera e propria civiltà della cura…
Sì, che significa sottolineare il tema della vulnerabilità. Non solo dei corpi ma anche dell’ambiente, e la crisi climatica ce lo sta dimostrando. La cura, questo lavoro costante di manutenzione, di presa in carico, di attenzione, di competenze che si gestiscono ogni giorno, deve diventare una forma di governo vera e propria, anche perché possiede delle competenze abituate a gestire la cultura del rischio, la complessità, la capacità di leggere le relazioni tra cose anche lontane. E’ una forma di governo che può e deve uscire fuori dalle case, dalla dimensione privata per diventare governo delle cose del mondo se vogliamo risolvere questo tema della vulnerabilità che è diventato l’emergenza assoluta.
Perché la cura non è considerata una priorità?
E’ una questione antica. Fa parte del come si è costruito nella nostra civiltà l’edificio antropologico, è la parte scomoda e dolorosa a cui pensare della nostra “mortalità”. Anche nelle società più evolute il tema è poco attraente.
Come si ripensano le “vecchie” città?
E’ un processo complesso e lungo. Intanto, attraverso delle operazioni di analisi dei dati, l’ascolto dei bisogni individuali della popolazione. Sono stati messi in atto degli strumenti, nel passato: in Italia siamo dei grandi sperimentatori, attuiamo strumenti anche formidabili e poi, passato quell’entusiasmo, vengono dimenticati in qualche cassetto. Si è parlato della Città dei 15 minuti, abbiamo inventato negli anni ‘80 i Piani regolatori degli orari delle città. Dopo una stagione di grande successo, però, sono stati abbandonati. Abbiamo anche avuto i bilanci di genere, che sono un modo di acquisire i dati della popolazione, degli individui, dei loro bisogni, ma suddivisi secondo una lettura di genere che ti restituiscono la diversità del carico e della forma di uso degli spazi della città da parte delle donne e degli uomini, e spiegano anche il perché. Conoscendo la realtà si può cercare di intervenire e migliorare, di rimuovere gli ostacoli di cui parla la Costituzione.
Qualche esempio di “città della cura”?
Porto il caso che conosco meglio, Stoccolma, dove vivo e lavoro: è un sistema che ha a che fare anche con la costruzione sociale di questo Paese, con la loro storia. Hanno individuato questo tema della conciliazione come un nodo che andava affrontato già da tempo, dalla fine della Seconda guerra mondiale, perché la popolazione era molto piccola e avevano capito che le donne dovevano entrare a far parte del corpus produttivo. Occorreva, quindi, risolvere la questione della gestione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Poi, con i governi socialisti c’è stata la riforma della famiglia che si lega anche allo strumento fiscale, diverso dall’impostazione italiana: il nostro è basato sulla famiglia, il loro è su base individuale. In Svezia c’è un modo molto differente di considerare le persone nel rapporto tra Stato e individuo: non va a confermare gli stereotipi e le differenziazioni tra uomini e donne ma cerca di guardare agli individui e di aiutarli tutti alla stessa maniera. Alla pari.
Nella vita di tutti i giorni, come si esprime la città della cura?
E’ una città dove puoi uscire con un qualsiasi apparato a rotelle, dal passeggino fino al deambulatore o la carrozzina, e non incontrare ostacoli da nessuna parte. Si accede ai mezzi pubblici, si sale sugli autobus senza problemi, ci si muove e si partecipa alla vita cittadina. E così si attiva anche un volano economico, perché tutta quella fascia di popolazione che è in congedo parentale, che è in pensione, che ha difficoltà, si trova a poter usare la città, e quindi anche a consumare, stimolando l’economia della città stessa. E vale la pena di ricordare che Stoccolma, quanto a concentrazione di abitanti, è paragonabile ad una città italiana di medie dimensioni.
È una grande questione culturale, quindi?
Certamente. Anche di volontà e pragmaticità, direi. Di capacità di trovare quali sono i meccanismi utili per attivare un processo virtuoso.
Come si stimola questo approccio?
Immettendo, per esempio, all’interno dei processi di costruzione dei passaggi obbligatori in cui non si possono ottenere il permesso a costruire o l’agibilità se non si dimostra il rispetto di alcuni requisiti di legge.
Questo per le costruzioni nuove. E per quelle esistenti?
Il processo è analogo. Quando si ristruttura, si può avere il permesso solo se si dimostra che si sta migliorando l’esistente, rimuovendo quegli ostacoli che l’esistente aveva e che non sono più tollerabili nella società che vogliamo costruire. E parliamo di tutto il costruito, non solo quello privato. Man mano che si migliora, si arriva un processo culturale, man mano che la struttura fisica rimuove gli ostacoli si rende evidente che la città non è solo un luogo per chi se la sa cavare. Ma per tutti.
di Valerio Ceva Grimaldi