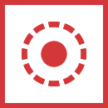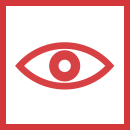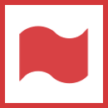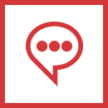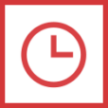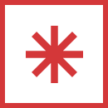Paolo Mattera, storico e consulente per Rai Storia, e docente di Storia contemporanea presso l’Università di Roma Tre, scrive a Spazio Pubblico
“Le parole sortiscono un effetto “performativo”. È con le parole, infatti, che prende forma il pensiero e che quindi noi esseri umani diamo ordine ai concetti nella nostra mente. E sono poi quei pensieri – costruiti intorno a quelle parole – che orientano le azioni, perché è in base agli schemi di valore vigenti che le persone decidono cosa è giusto fare, cosa non lo è, quali priorità scegliere e come agire. Qualcuno potrebbe concludere che siano delle astrazioni prive di effetti pratici. Ma non è così, anzi: la storia ci dimostra che questi meccanismi mentali e comportamentali si sono spesso verificati nel passato, provocando terribili tragedie.
Negli ultimi 25 anni del XIX secolo milioni di italiani emigrarono in America per sfuggire a un destino di povertà ed emarginazione in patria. L’accoglienza non fu però positiva. La classe dirigente (che si riteneva l’espressione più pura dei valori fondanti l’America) era indicata con l’acronimo Wasp (White Anglo-Saxon Protestant): Protestanti, Anglo-sassoni e Bianchi. Gli italiani non erano né protestanti né anglo-sassoni, e già solo per questo suscitavano particolare diffidenza. Inoltre, con la divisione degli esseri umani in razze, che potevano essere facilmente distinte mediante il criterio di “bianchezza”, gli italiani non apparivano bianchi come gli altri. Per di più accettavano i lavori più umili fatti dagli afro-americani (per esempio nei campi di canna da zucchero), quindi erano considerati quasi “come i neri”. Molti americani, perciò, si opponevano all’idea di promuoverne l’integrazione e riconoscerne la cittadinanza.
Questi stereotipi generarono nomignoli e parole che definivano spregiativamente gli italiani e che, in un perfetto circolo vizioso, alimentarono ulteriormente il razzismo. Gli insulti più frequenti erano “dago” e “wop”, che significavano più o meno “guappo” o “cafone”, vale a dire un uomo rozzo e incivile, potenzialmente pericoloso. Dalle conversazioni di strada questi termini passarono ai giornali, facendo compiere un salto di qualità alla diffusione della mentalità discriminatoria. L’austero e già molto autorevole “New York Times” più volte tra il 1874 e il 1887 pubblicò articoli dove gli italiani venivano indicati come «disgraziatamente poveri e non qualificati», esseri di fatto inferiori perché «anelli di una catena evolutiva discendente». E in un preoccupato editoriale in prima pagina del 1882, dal titolo I nostri futuri cittadini, il quotidiano osservò: «Da quando esiste New York non è mai esistita fra gli immigrati una classe così bassa e ignorante come quella degli italiani del Sud che hanno affollato i nostri moli negli ultimi anni».
Era il punto più alto del disprezzo? Tutt’altro. Una vignetta della rivista “Judge” raffigurò infatti uno Zio Sam molto preoccupato mentre le navi provenienti «dai bassifondi dell’Europa» arrivavano con – da notare la parola – un «carico» di immigrati piccoli e malvagi, portatori di mafia, anarchia e malattie, talmente inferiori da somigliare più a dei ratti che agli esseri umani. Visto che erano diversi, la vita con loro appariva impossibile. E come ce ne si poteva liberare? La risposta arrivava da un articolo corredato da una vignetta (divenuta poi famosa) pubblicata nel 1890 da “The Mascot” a New Orleans, dove l’illustratore dava due suggerimenti molto semplici per sbarazzarsi degli italiani: arrestarli o buttarli in mare. In questo secondo caso il metodo era quello di fare un apposito “carico” in una gabbia sul molo e calarli verso il mare, abbandonandoli al loro destino.
Il disprezzo e le parole divennero ben presto senso comune, generando comportamenti che non si limitavano più al feroce sarcasmo o all’invettiva verbale, ma sortivano effetti molto concreti. Gli italiani venivano sistematicamente discriminati nell’affitto delle case, nell’assegnazione dei lavori e perfino nell’accesso ai servizi. E quando anche nelle scuole o negli uffici cominciarono ad essere usati normalmente nomignoli spregiativi, allora saltarono tutte le categorie di giustizia e cittadinanza, portando a una piena legittimazione formale del razzismo e della discriminazione.
Se ne ebbe una tragica riprova nel celebre caso verificatosi a New Orleans. Nel 1890 fu ucciso il popolare capo della Polizia Hannessy. Per trovare i colpevoli fu semplice individuarli nel corpo estraneo alla comunità: gli italiani. L’idea era in fondo semplice: trovato il bubbone che comprometteva il sano funzionamento dell’organismo sociale, bisognava solo estirparlo e tutto sarebbe tornato alla normalità. E così anche i magistrati che istruirono il processo non esitarono a definire gli italiani con tutti i termini spregiativi impiegati nelle strade e sui giornali. Diversi membri della comunità italiana furono arrestati e processati per omicidio. L’accusa fu condotta con particolare veemenza, invocando l’esemplare punizione verso questa razza inferiore che intaccava la vita armoniosa della città. C’era però un problema: mancavano le prove. E al momento della sentenza, nel marzo 1891, scattò l’assoluzione. Lo sconcerto si diffuse in tutta la città: i «wop» non potevano essere innocenti, si trattava di un errore. Ad aggravare la situazione sopraggiunse la decisione dei funzionari di polizia di non scarcerare subito gli imputati assolti. Questo comportamento delle istituzioni fornì una fortissima legittimazione al razzismo dilagante in città: se la polizia li trattiene – si diceva nelle strade – allora c’è qualcosa che non va. La sorpresa per la sentenza divenne così rabbia collettiva: il 14 marzo 1891 migliaia di persone si radunarono presso Canal Street per «porre rimedio agli errori della giustizia» (secondo l’invocazione di un giornale locale), aggredirono e infine linciarono undici italiani, nessuno dei quali era coinvolto nella morte di Hannessy. Non ci furono conseguenze per gli assalitori. In fondo – si pensava – gli italiani non erano come gli americani, e perciò una sonora lezione ad alcuni di loro avrebbe funzionato da ammonimento anche per gli altri.
La progressiva estensione delle parole di disprezzo, dalle conversazioni occasionali ai giornali, fino ai politici e alle istituzioni, aveva sortito l’effetto di legittimare progressivamente comportamenti concreti sempre più aggressivi verso individui considerati inferiori e non “umani” come gli altri. Da qui il passo era poi stato breve per arrivare alla violenza. Sarebbero stati necessari decenni di mobilitazione democratica e di campagne per i diritti civili affinché le comunità italiane negli Stati Uniti uscissero da questa condizione di minorità e riuscissero a integrarsi nella comunità. Ma prima di allora, il razzismo, nutrito da parole spregiative e aggressive, aveva prodotto molto dolore e provocato terribili tragedie”.