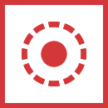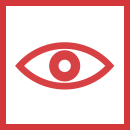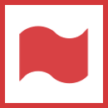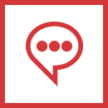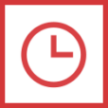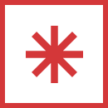Hanno fatto molto discutere le parole di Giorgia Meloni sulla tessera della Cgil e la libertà di scelta. A tal proposito, Paolo Mattera, storico e consulente per Rai Storia, ha inviato a Spazio Pubblico un contributo per ricordare l’importanza della libertà di associazione e i periodi più bui della vita sociale e politica italiana in cui l’opportunità di scegliere veniva resa impossibile dal fatto che di tessera ce n’era una soltanto. Di seguito il suo excursus.
“Nel XX secolo la storia mostra un dato di grande interesse: il nesso tra diritti e organizzazioni collettive. Infatti, nei primi venti anni del ‘900 l’impetuosa crescita delle organizzazioni sindacali e politiche portò un progressivo miglioramento di molti contratti, fino alla conquista delle otto ore dopo la Grande Guerra.
Il fascismo: una sola associazione e nessun diritto
Poi arrivò il fascismo. Mussolini e i dirigenti fascisti sapevano di governare una società di massa e di non poter riportare all’indietro le lancette dell’orologio. Il meccanismo fu quindi più sottile e – dal loro punto di vista – efficace. Spesso si è infatti sentito dire (e si sente ancora) che tra le “cose buone” fatte dal fascismo c’erano le pensioni e i contratti sindacali. E come sempre accade con gli stereotipi, in queste affermazioni c’è una base di verità. Si tratta però di una verità alterata e contraffatta.
Come funzionavano realmente le cose? La legge sindacale del 1926 introduceva una norma drastica: il divieto di sciopero a fini rivendicativi. Come affrontare allora gli eventuali contrasti fra imprenditori e lavoratori? Per rispondere la legge introduceva il riconoscimento giuridico dei sindacati, ma – ecco il punto – per una sola organizzazione, che doveva essere di sicura “fede nazionale” e avrebbe stipulato contratti validi per tutti. Insomma, il sindacato era in effetti riconosciuto, ma non era libero. E così gli imprenditori potevano assumere e licenziare con un’autonomia che spesso sconfinava nell’arbitrio. Detto in altre parole: la mancanza della libertà di associazione si traduceva di fatto nella cancellazione anche delle altre tutele.
I primi anni della Repubblica e gli ostacoli alla libertà di associazione
Caduto il fascismo, tutto questo apparato normativo fu abrogato. Al suo posto venne subito approvata una nuova legge? No, creando così gravi contraddizioni. Da una parte c’era la Costituzione che indicava nei diritti sociali un presupposto per l’esercizio dei diritti individuali, perché nessuno sarebbe stato libero e pienamente cittadino se oppresso dal bisogno e esposto a ricatti materiali. D’altro canto, in assenza di una legge specifica, il lavoro finiva col ricadere sotto le regole stabilite nel codice civile del 1942, che considerava il rapporto di lavoro un semplice contratto privato, senza tutele particolari per i dipendenti. In più, l’imprenditore veniva denominato “capo” dell’azienda: una parola emblematica dell’ispirazione verticistica e autoritaria della legislazione. Questo contrasto fra le tutele progettate dalla Costituzione e le indicazioni fornite dal codice richiedeva un intervento politico che però non si realizzò. La Guerra Fredda alimentò l’anticomunismo, che si innestava sulla preesistente idea delle classi dirigenti che i lavoratori fossero una “classe pericolosa” incline alla sovversione, da contenere e irregimentare. Risultato: nelle fabbriche i militanti sindacali venivano guardati con sospetto e le libertà costituzionali di espressione e associazione ostacolate con impedimenti di ogni tipo.
Lo Statuto dei lavoratori
Solo negli anni ’60, con l’ingresso del Partito socialista al governo, iniziò un lungo percorso che nel 1970 avrebbe portato allo Statuto dei Lavoratori. Una legge ancora oggi ricordata come una pietra miliare. Non caso: i due ispiratori, i giuristi Gino Giugni e Federico Mancini, costruirono un impianto normativo complesso, che reggeva su due pilastri. Primo: sostituire gli articoli del codice civile con norme apposite che riconoscevano esplicitamente le libertà dei dipendenti e contenevano il licenziamento a casi da motivare con precisione (la famigerata “giusta causa”). Molti giuristi si sarebbero fermati qui. Ma non Giugni e Mancini, che ammonivano: chi controllerà l’effettiva applicazione della legge anche nel più lontano luogo di lavoro? Inoltre, cosa accadrebbe se gli imprenditori eludessero le norme, con pressioni economiche sui singoli, con promesse o minacce, mettendo i dipendenti in reciproca competizione? Nel mercato – continuavano Giugni e Mancini – i rapporti di forza non erano paritari, per cui i diritti individuali, pur introdotti per legge, rischiavano di restare una semplice astrazione. Ecco allora il secondo pilastro: le norme che stabilivano per legge la piena libertà di associazione sindacale nei luoghi di lavoro. Chiaro l’intento: equilibrare il potere degli imprenditori con la forza dell’organizzazione dei lavoratori. La presenza del sindacato serviva per assicurare l’esercizio delle libertà individuali.
Prospettive
Da allora molta acqua è passata sotto i ponti. La deindustrializzazione e lo spostamento di molti lavoratori nei servizi, l’avvento sul mercato del lavoro mondiale della concorrenza delle grandi masse cinesi e indiane, la gara al ribasso tra le varie economie che riducono i salari per attrarre i capitali: queste sono solo alcune delle sfide poste dal recente passato e per il futuro. Affrontarle richiederà grandi capacità di innovazione e di adattamento, senza però mai dimenticare l’insegnamento del passato: diritti individuali e associazioni collettive camminano insieme. Una riforma che diminuisce le seconde porta anche a una riduzione dei primi”.